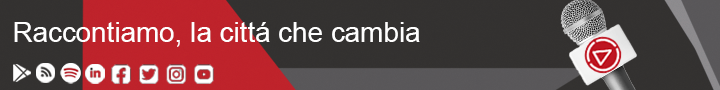CARCERI: UECOOP, 62 BIMBI DIETRO LE SBARRE, IL 58% AL CENTRO SUD
Dei 62 bambini fino a 6 anni che si trovano ospiti delle carceri italiane per stare vicini alle loro mamme il 58% è “dietro le sbarre” al centro sud con il record di oltre un quarto proprio nella sezione femminile di Rebibbia. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in relazione al dramma che si è consumato nel penitenziario di Rebibbia dove una madre tedesca ha gettato nella tromba delle scale i suoi due bambini di 4 mesi deceduto sul colpo e di 2 anni per il quale è stato avviato l’accertamento della morte cerebrale. Un dramma – sottolinea Uecoop – che colpisce tutti gli operatori socio assistenziali attivi anche nelle carceri italiane, dove si trovano 52 mamme di cui quasi la metà straniere. Il mondo dietro le sbarre è fra i più delicati e complessi dove il tempo della pena detentiva può essere impiegato in progetti di recupero fra studio e lavoro che – conclude Uecoop – aiutano i detenuti a individuare una prospettiva per quando verrà il momento di lasciarsi alle spalle i cancelli del carcere.
Nelle carceri italiane ci sono 60 bambini detenuti. Hanno da pochi mesi a sei anni e vivono dietro le sbarre. Condividono la reclusione delle madri, anche se il regime carcerario a cui sono sottoposti è attenuato rispetto al resto della popolazione carceraria. Non hanno fatto niente (e cosa potrebbero mai fare?), eccetto nascere al momento sbagliato, in prossimità di un arresto o una condanna.
L’ingresso in carcere dei bambini è una scelta della donna. Che però, quasi sempre, non ha una vera opzione. Spesso il marito è in carcere o non ci sono altri parenti a cui affidare il bimbo. Il numero dei bambini nei penitenziari è più o meno sempre costante negli anni. Non influiscono i vari provvedimenti di legge. Dal 1975 (la legge 354) a oggi (la legge 62 del 2011) ci sono stati cinque interventi legislativi. Ma i bambini restano sempre lì. Non si contano, invece, le promesse solenni di quasi tutti i ministri della Giustizia che si sono succeduti negli ultimi dieci anni (senza andare troppo indietro con il tempo).
Il ministro Clemente Mastella nel 2007 partecipò a un convegno dal titolo: «Che ci faccio io qui? Perché nessun bambino varchi più la soglia di un carcere». Nel 2009 lo sostituì Angelino Alfano e dichiarò: «Un bambino non può stare in cella. Approveremo una riforma dell’ordinamento carcerario che consenta di far scontare la pena alle mamme in strutture dalle quali non possano scappare ma che non facciano stare in carcere il bambino». Poi fu il turno del ministro Paola Severino: «In un Paese moderno è necessario offrire ai bambini, figli di detenute, un luogo dignitoso di crescita, che non ne faccia dei reclusi senza esserlo». Era il 2012. L’anno dopo in via Arenula arrivò Anna Maria Cancellieri: «Stiamo lavorando perché vogliamo far sì che non ci siano mai più bimbi in carcere». Infine, l’attuale ministro della Giustizia Andrea Orlando che nel 2015 promise: «Entro la fine dell’anno (2015, ndr.) nessun bambino sarà più detenuto. Sarà la fine di questa vergogna contro il senso di umanità».
L’istituto penitenziario che reclude il maggior numero di bambini si trova a Roma ed è il Rebibbia femminile «Germana Stefanini», uno dei più attrezzati e meglio tenuti. Ci vivono quindici bambini, quasi tutti sotto i tre anni di età. Ma prima della sentenza Torreggiani (la decisione con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo stabilì che «il prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana») se ne contavano ventuno. La maggior parte delle mamme sono Rom ma troviamo anche un’italiana.
La prevalenza Rom si spiega con l’alta percentuale di recidiva che impedisce loro di accedere alle pene alternative. Così vivono con i figli nelle celle, anche se di giorno le porte sono aperte. Alle 20,00 una poliziotta penitenziaria le rinchiude. I bambini crescono con i ritmi carcerari, tra divise e chiavistelli. Un’eccezione sono considerati gli Icam, Istituti a custodia attenuata per madri detenute (il progetto pilota partì a Milano) che si distinguono unicamente per il fatto che ci sono ambienti più familiari, i poliziotti non indossano la divisa ma abiti civili e c’è una maggiore presenza di educatori.
Restano le sbarre alle finestre, le porte blindate, la videosorveglianza e il controllo degli operatori. «Chiedono perché li rinchiudono, credono di aver fatto qualcosa di sbagliato e piangono» ci dice una mamma. Non sanno di essere in un carcere ma percepiscono le restrizioni. I racconti sono questi: «Di notte mio figlio non dorme, si affaccia continuamente alla cancellata, chiama la guardia e chiede “Mi apri?”; Quando so che si avvicina l’ora della chiusura lo porto in bagno ma lui capisce, indica gli agenti con il dito e si nasconde, è brutto»; «I bambini qui diventano aggressivi, non hanno relazioni sociali. Tra l’altro vedono solo donne e manca del tutto una figura maschile».
Una situazione che induce a gridare allo scandalo ma che, in realtà, è molto complessa perché mette il legislatore nella difficoltà di contemperare tre diverse necessità, ugualmente sacrosante: garantire l’espiazione della pena, tutelare i diritti del bambino così come il rapporto che deve esserci tra una madre e il figlio poco più che neonato. Cosa, quest’ultima, che fa escludere a priori l’ipotesi di separare il figlio dalla madre al momento dell’ingresso in carcere. I danni si colgono il sabato, quando i bambini possono oltrepassare il confine carcerario grazie all’associazione «A Roma insieme». La fondò Leda Colombini, onorevole del Pci, un passato di grande sofferenza personale e di lotta per i diritti che la portò dai campi di riso ai banchi del Parlamento. Volle fortemente i cosiddetti «Sabati di libertà», giornate che da più di vent’anni rappresentano l’unica boccata d’ossigeno per i bambini detenuti. Elisa, Roberta, Paola, Alessandra, Fabrizio e Vanessa sono i volontari che ci accompagnano. Li chiamano «articolo 17» con riferimento all’ordinamento penitenziario che consente l’ingresso in carcere a persone esterne purché legate a un progetto. Spesso fanno tutt’altro mestiere.
Roberta è un avvocato di un noto studio legale romano. Paola è un’amministrativa dell’ospedale San Giovanni. Poi c’è chi come Fabrizio lavora nel mondo del volontariato, Vanessa che vuole fare un’esperienza compatibile con il suo percorso di studi o Elisa che lavorava come pubblicitaria e dopo aver scoperto la realtà dei bambini in carcere si è iscritta all’Università ed è diventata una educatrice.
Un pullman dell’Atac messo a disposizione dal Comune di Roma (per il servizio l’Atac chiede 25mila euro l’anno) preleva i bimbi da Rebibbia e li porta all’esterno. La nostra presenza coincide con la visita al mare di Ladispoli e alla casa famiglia «Carolina Morelli» gestita dalle suore dell’ordine «Figlie di Maria ausiliatrice». «Molti di loro non sanno cosa siano gli spazi aperti, quando arrivano sulla riva restano stupiti ma anche spaventati», nota Giovanni Giustiniani, volontario della prima ora.
E’ impressionante vedere dei marmocchi che a stento si reggono in piedi varcare i cancelli del carcere. Così come fa specie sentirli pronunciare poche parole ma alcune con estrema chiarezza: porta, chiave, apri, chiudi.
Restano cupi fin quando non scendono e i volontari li fanno giocare. Arrivano sulla spiaggia procedendo con prudenza. Si fermano, guardano e scoprono. Alcuni restano attaccati ai volontari. Come Eliot che stringe forte il dito di Claudio Enei, l’autista che li accompagna ogni settimana. «Prima era solo un lavoro. Ora, quando arriviamo, tolgo la divisa dell’Atac e divento un volontario a tutti gli effetti. Spesso mi scambiano per il papà», racconta. Subiscono una metamorfosi quando devono risalire sul pullman per il ritorno. Non è solo per la fine di una giornata di giochi, come fanno tutti i bambini. Associano l’imbrunire con la chiusura delle celle e s’intristiscono. Qualcuno piange, sbatte la manina sul vetro dell’autobus.
Rientrati a Rebibbia non corrono verso le rispettive mamme. «Più di una volta è capitato che restano attaccati addosso e non vogliono andare dalla mamma» ricorda Paola, un’altra volontaria. Gli aneddoti che raccontano sono infiniti. Come quel giorno in cui capitò che un agente lasciò una chiave sul tavolo. Uno dei bimbi la prese e corse dalla mamma: «Mamma, vieni, ti porto fuori, ci sono un sacco di cose belle». __________________
 Unica Radio Raccontiamo la città che cambia
Unica Radio Raccontiamo la città che cambia