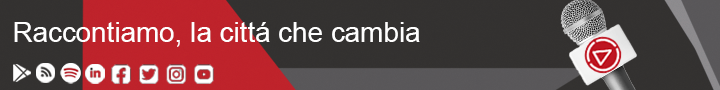La storia dello smart working (SW) nel nostro Paese è sotto molti aspetti esemplare. L’impianto culturale “standard” dell’impresa italiana, in particolare delle PMI, si presenta in forma rigorosamente “solida”. Il luogo di lavoro è lo spazio privilegiato attraverso il quale è possibile controllare lo svolgimento delle attività per le quali i dipendenti sono pagati. Con una tendenza insana a sviluppare logiche di valutazione informale della produttività in ragione delle ore di lavoro passate in ufficio. Dentro questo scenario, culturale e organizzativo, i casi di lavoro realmente “agile” sono stati relativamente pochi.
Negli anni precedenti all’arrivo del Covid-19, alla diffusione delle prassi di SW, le aziende che si muovevano secondo questa modalità erano quelle relative al marketing.
La crescita di un nuovo modo di lavorare
Gli sforzi profusi per diffondere lo SW arrivano a dare i primi frutti proprio negli ultimi anni, tanto da rendere possibile anche l’avvio di una quantificazione del fenomeno. Si tratta evidentemente di numeri tutto sommato ancora molto piccoli, e soprattutto molto lontani dalle medie registrate nel periodo in Europa. Nel corso del 2019 lo avrebbero praticato poco più di 570mila lavoratori e lavoratrici.
Intendiamoci: una rivoluzione ha i suoi tempi e s’inizia sempre grazie all’azione di quelle che il grande storico inglese Arnold Toynbee definiva “minoranze creative”. Ma questi dati ci dicono che quella in atto fino al Covid-19 non era ancora neppure l’avanguardia di una vera rivoluzione del lavoro. Tutto ciò è imparagonabile con il 40% di lavoratori che potevano disporre di modalità di telework in Olanda o del 35% registrato in Svezia.
La storia dello Smart working
C’è dunque una seppur piccola e breve storia dello SW anche nel nostro Paese. Una storia che, passa attraverso il lungo lockdown cui 8 milioni di lavoratori e lavoratrici sono stati costretti a lavorare in casa. Perdendo la sua connotazione di puro strumento a complemento di una trasformazione della cultura organizzativa e di gestione dell’impresa, per assumerne una differente, utopica e (a nostro avviso) pericolosamente irrealistica: quella dell’introduzione a una nuova “civiltà del lavoro” come liberazione del lavoro dai limiti di tempo e di luogo imposti (come già aveva colto la grande sociologia storica di Max Weber) dallo sviluppo razionalizzante della modernità e della società industriale.
Di fronte a queste utopie della totale “remotizzazione” del lavoro e dunque della riduzione del classico ufficio, crediamo occorra un soprassalto di realismo. Necessario per salvaguardare ciò che di propriamente “umano” c’è nel lavoro, ma anche per salvare lo stesso SW dalle sue pericolose radicalizzazioni. Il tema dello Smart working durante la pandemia, ha dato un’utile lezione. Abbiamo scoperto che ci mancano i colleghi dell’ufficio, come ai ragazzi e ancora di più ai bambini mancano i compagni di banco o di corso. Certo, ci sono internet e la tecnologia a darci una mano, ma non è facile stare da soli, per settimane.
Smart working: un’inevitabile costrizione
Lavorare da casa, nelle attuali condizioni, non è la stessa cosa e non soltanto perchè non è stata una nostra scelta, ma un’inevitabile costrizione. La verità è che abbiamo scoperto, stando a casa lavorando ogni giorno da quel luogo (invece che viverlo solo per godere dei nostri affetti e del nostro tempo libero), che prima di amare gli spazi di fondamentale libertà dal lavoro, amiamo proprio il lavoro e lo amiamo nel luogo dove il lavoro si fa normalmente: negli uffici, nelle fabbriche, nelle scuole, in ogni posto dove si stia in relazione con gli altri e per gli altri. Lavorare, insomma, non è semplicemente “produrre”: è stare immersi nell’ambiente che il lavoro genera e riproduce. Questo è il “bene comune” che ci è stato rapinato dal “male comune” del virus.
Lavoro da casa: quel che il lockdown non ci può insegnare
Ed è male fare del virus un alleato per sostenere che proprio la sua comparsa ci avrebbe finalmente sospinto, volenti o nolenti, dentro una nuova, utopistica condizione, per organizzare la nostra vita e il nostro lavoro. A smentire simili assunti ci hanno pensato alcune recenti ricerche come, ad esempio, quella del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica dalla quale emerge un vissuto molto problematico da parte di chi (lavoratore dipendente) ha dovuto da un giorno all’altro trasferire il proprio lavoro in casa: bassa soddisfazione e bassa produttività self reported sono segnali rilevanti, certo dettati da una condizione senza scampo, ma altrettanto certamente capaci di metterci in guardia dal rischio di pensare che quel che siamo stati in grado di fare in emergenza possa diventare regola nel new normal che stiamo costruendo.
Sono cose che potevamo immaginare anche senza studiare le ricerche, in fondo. Le sapevamo già, perchè sono emerse parlandone con i colleghi di lavoro o con i vicini di casa (ovviamente su Zoom o con Webex).
Il drammatico lockdown e il “tutti a casa” generalizzato non ha giovato al senso di libertà e di serenità che il vero SW dovrebbe generare, come quando lo si vive stando in un contesto aziendale basato su logiche partecipative e realmente responsabilizzanti.
 Unica Radio Raccontiamo la città che cambia
Unica Radio Raccontiamo la città che cambia