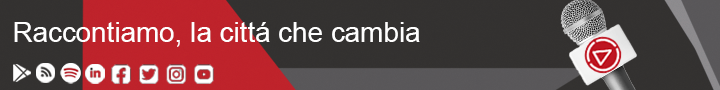UN CONTO è la sfortuna. Un altro è andarsela a cercare. Una cosa, insomma, è ritrovarsi contagiati per una qualche disattenzione, un’altra è farsi infettare di proposito dal virus Sars-Cov2.
Anche se si hanno le migliori intenzioni di questo mondo: per esempio, quella di capire se il vaccino funziona o meno contro la Covid-19, e sperabilmente accelerare i tempi del suo arrivo sul mercato, per arrestare l’epidemia e salvare l’umanità. Uno scopo nobilissimo che dovrebbe muovere i volontari che si arruoleranno in uno “human challenge trial”: uno studio clinico in cui giovani individui sani, dopo aver ricevuto una dose di vaccino anti-Covid, vengono esposti a dosi sempre crescenti di coronavirus, per capire se effettivamente la protezione immunitaria sia sufficiente oppure no.
32.000 volontari
Già 32 mila persone dagli Stati Uniti e da altri 139 paesi hanno aderito a una piattaforma online, 1DaySooner, dando la loro disponibilità a partecipare a questo tipo di studi.
Più concreto potrebbe essere invece progetto “Covid-19 challenge study” destinato a partire nel gennaio 2021 al Royal Free Hospital di Londra, secondo quanto ha annunciato lo scorso 20 ottobre il governo britannico, che per questo ha pagato anche 10 milioni di sterline alla Open Orphan, l’azienda irlandese che gestirà il trial. Dovrebbe, dicevamo. Perché il progetto deve ancora ricevere il via libera dalla MHRA, l’agenzia regolatoria britannica, e l’approvazione del comitato etico.
In effetti i dubbi sollevati dallo studio non sono pochi. E la discussione nella comunità scientifica internazionale è accesa. Stiamo oltrepassando un limite? “Ci muoviamo certamente su un terreno incognito”, commenta Gilberto Corbellini, che insegna Bioetica e Storia della Medicina alla Sapienza Università di Roma.
Anche se, a dire il vero, non è certo la prima volta che degli individui sani, più o meno volontari, vengono esposti all’agente patogeno a scopo di ricerca. “Lo fece Jenner, per esempio, quando nel 1796 fece le sue sperimentazioni sul figlio del giardiniere. Inoculò il vaccino nel ragazzo, e poi il virus del vaiolo umano. Oggi non sarebbe pensabile, ma non dobbiamo dimenticare da dove viene la medicina”, dice Corbellini. Nessuno, all’epoca, ebbe niente da dire. Ma oggi è diverso, e le perplessità che ruotano intorno al Covid-19 challenge study sono tante.
Nessuna cura
La prima, e forse la più importante: per la malattia provocata dal coronavirus non abbiamo una cura. In questi mesi abbiamo provato tante strade, alcune buone altre meno, che hanno aiutato i medici a ridurre i danni, ma non abbiamo un farmaco salvavita. “E sappiamo anche – continua Corbellini – che una percentuale seppur piccola degli infetti anche giovani, cioè nella fascia di età considerata nel Covid-19 challenge study (18-30) potrebbe sviluppare una forma grave della malattia, che in assenza di una terapia certa e sperimentata potrebbe portare rapidamente alla morte.
Non c’è insomma un piano B nel caso in cui le cose si mettessero male per il volontario. E’ una scelta eticamente sostenibile? Beh, si dirà, ma i volontari sapevano a cosa andavano incontro. Avranno pur firmato un foglio, un consenso informato.
Quanto essere informati?
Ma quanto può essere informato un consenso se sappiamo ancora così poco di questo virus, degli organi che colpisce, delle reazioni che scatena? “Nell’ambito della sperimentazione – spiega Elisabetta Sirgiovanni, che fa ricerca in neuroetica al Dipartimento di Medicina molecolare dell’ateneo romano – il consenso prevede che i partecipanti allo studio vengano informati nel modo più approfondito possibile. Finalità della ricerca, procedure, vantaggi, rischi o inconvenienti, durata, diritto alla riservatezza, diritto di ritirarsi dallo studio, diritto all’oblio dei propri dati, e così via.
Il consenso non può essere concepito come un modulo da firmare e lì si chiude tutto, ma come un processo che si svolge per tutto il corso della sperimentazione e può essere revocato in qualsiasi momento. I cosiddetti “challenge studies” prevedono di sottoporre più volte le procedure di consenso ai partecipanti, in particolare perché possono sopravvenire nuovi dati che richiedono un nuovo consenso.
I partecipanti hanno il diritto di esplicitare i propri dubbi e chiedere ragguagli agli sperimentatori in qualsiasi stadio della ricerca, e soprattutto devono essere messi nelle condizioni di serenità e di non pressione psicologica per potersi ritirare dallo studio in qualsiasi momento, se lo ritengono e se è preferenza maturata anche successivamente”.
Troppa fretta
C’è un altro dubbio. Lo scopo principale degli human challenge studies è in genere quello di saltare le tappe: accorciare i tempi per portare prima sugli scaffali un medicinale ritenuto strategico. “In questo caso, però, non è chiaro di quanto riusciremmo ad abbreviare il percorso”, commenta ancora Corbellini. Ci saranno davvero vantaggi in termini di tempo? In genere gli studi di fase tre, quelli in cui il nuovo vaccino viene testato su decine di migliaia di volontari, possono ottenere risultati significativi dopo diversi mesi. In questo caso i partecipanti sarebbero una cinquantina e i risultati potrebbero arrivare in sei settimane, dicono i promotori del progetto.
Cosa significa in termini di vite umane? Josh Morrison, il fondatore della piattaforma 1DaySooner, ha fatto i conti: “Ogni giorno risparmiato potrebbe salvare 7120 persone. Accorciare di tre mesi lo sviluppo di un vaccino risparmierebbe oltre mezzo milione di vite”. Ma sono numeri che non trovano riscontri in altri studi. Insomma, non è affatto detto che un azzardo del genere faccia risparmiare del tempo.
La salute dei volontari
Dietro le perplessità c’è anche una questione sociale di chi guarda oltre la pandemia di Covid-19. “Se dovesse mai succedere qualcosa a uno dei volontari nel trial, saremmo sommersi da un’ondata anti-vaxx che non ci possiamo proprio permettere”, ammonisce ancora Corbellini. E’ già successo in passato con la terapia genica: una sperimentazione volontaria non andata a buon fine ha bloccato lo sviluppo della ricerca per due decenni negli Stati Uniti.
Infine: questa dimensione “eroica” della medicina rischia di provocare un bias nella selezione dei partecipanti, continua Corbellini. I volontari, in quanto eroi, sono come è evidente tutti giovani e belli. Guccini a parte, si rischia di sperimentare un vaccino su una categoria molto selezionata di individui, trascurando l’efficacia e la sicurezza su altre categorie come anziani e bambini.
E poi, cosa daremo in cambio a chi ha messo la sua salute al servizio dell’umanità? Davvero c’è solo altruismo alla base delle scelte dei volontari, o magari un compenso in denaro aiuterebbe? La questione è complessa, come sottolinea Sirgiovanni. “I biologi evoluzionisti e la teoria dei giochi in economia ci insegnano che l’altruismo viene eseguito per ottenere reciprocazione, anche se non immediata e cosciente.
Il compenso
La questione del compenso nella sperimentazione è una questione rilevante per la bioetica, perché ha delle implicazioni di giustizia distributiva. Ad esempio, l’OMS raccomanda che nella selezione dei partecipanti dei challenge studies si prediliga un criterio medico: scegliere quelli giovani e sani ma che provengono da un ambiente a più alto rischio di infezione.
Tuttavia, chiarisce che questo ambiente non deve riflettere povertà o ingiustizia sociale perché altrimenti si tratterebbe di sfruttamento di soggetti vulnerabili”. Anche quella dell’entità del pagamento è una questione dibattuta. Un pagamento troppo consistente può costituire, anziché un incentivo, una forma di manipolazione o coercizione, perché può spingere individui in difficoltà economica a scegliere di partecipare ad uno studio sperimentale esclusivamente su queste basi, quindi impedendogli di considerare in maniera lucida i rischi.
Il problema di concentrare la sperimentazione solo verso gruppi socio-economici bassi è contestabile sia sul piano scientifico che etico perché rischierebbe di limitare la variabilità del campione e quindi l’affidabilità dei risultati, e produrrebbe discriminazioni e ingiustizie. Insomma, un ginepraio.
Poca attenzione ai rischi
Nel tentativo inglese, conclude Corbellini, sembra mancare una attenta valutazione dei rischi medici, degli aspetti etici e delle ricadute sociali di questo tipo di studi. E però: quella della pandemia da Covid-19 è una situazione di emergenza che ci confronta con scenari diversi da quelli ordinari. I “challenge studies” – che non sono una novità – sono gestiti sotto il controllo dei comitati etici di ricerca, che ne valutano i vari aspetti circostanziali sia di design sperimentale che etico. Ma, dice Sirgiovanni, c’è generale consenso circa la loro liceità. E forse, nel mezzo di questo dramma planetario, siamo più pronti a spostare limiti che credevamo inamovibili.
 Unica Radio Raccontiamo la città che cambia
Unica Radio Raccontiamo la città che cambia