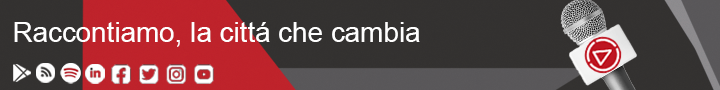Non c’è una regola valida per tutti ma tre azioni possono fare la differenza. Ecco chi deve ricoverarsi e chi può curarsi a casa propria
NON abbiamo ancora farmaci che possono rallentare o bloccare Covid-19 ai primi sintomi, una volta contratta l’infezione. Ce ne sono di promettenti in arrivo (gli anticorpi monoclonali) ma intanto tre azioni possono fare la differenza. E’ importante capire quando recarsi in ospedale.
Uno: realizzare degli “avamposti” dell’ospedale sul territorio dove medici esperti possano valutare ogni caso con strumenti adeguati. Due: ricoverare chi ne ha bisogno prima che i sintomi e la saturazione dell’ossigeno diventino critici, per fare la terapia giusta al momento giusto in ospedale. Tre: monitorare a distanza, ma strettamente, gli altri, per seguire l’evoluzione della malattia.
Non c’è un bignamino da seguire o una regola valida per tutti: per esempio, gli stessi valori di saturazione di ossigeno in una persona di 40 anni non hanno lo stesso significato in una di 70.
I tre fattori di rischio di progressione
Circa il 10-15% dei casi lievi progredisce verso forme severe. Il primo fattore di rischio è l’età: la curva della mortalità cresce dai 50 anni e si impenna in modo significativo dai 70. Il secondo sono le comorbilità, cioè la presenza contemporanea di malattie croniche: polmonari, cardiache, sovrappeso e obesità, diabete. Il terzo è il sesso maschile: uomini e donne contraggono il coronavirus allo stesso modo. Tuttavia la progressione verso la malattia grave e la mortalità sono più alte nei primi.
Che cosa sono gli hotspot
“Oggi sappiamo che i sintomi gravi compaiono generalmente dopo 7-8 giorni, in media: tenere a casa così a lungo i pazienti che non migliorano, soprattutto se presentano uno o più dei fattori di rischio di progressione, è pericoloso”, dice Paolo Bonfanti, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Gerardo e professore di Infettivologia all’Università di Milano Bicocca.
“Dall’altra parte – prosegue – sia nella prima sia nella seconda ondata abbiamo visto che i numeri dei malati crescono molto velocemente e altrettanto rapidamente gli ospedali si saturano: diventano una fortezza, con i pronto soccorso intasati a fare da ponte levatoio. Non solo: per i medici di medicina generale diventa difficile far fare esami di primo livello per capire quando è necessario ricoverare il paziente. Da qui l’idea di creare gli hotspot: punti di snodo per facilitare l’accesso dei pazienti, riducendo la distanza tra ospedale e territorio”.
Ecco come funzionano gli hotspot: il medico di medicina generale invia il paziente che sospetta o sa di avere Covid-19; qui i medici fanno la visita clinica il tampone e le prime indagini con ecografia polmonare per valutare se è in corso una polmonite. Grazie a queste indagini è possibile capire per tempo chi necessita dell’ospedale e chi invece è un caso lieve e può essere seguito a casa.
Cosa si intende per “forma lieve”
Cosa vuol dire “caso lieve”? Nella definizione rientra chi ha febbre (superiore a 37,5°C), malessere, tosse, mal di gola, congestione nasale; ai sintomi si aggiungono mal di testa, dolori muscolari, nausea, vomito, diarrea, perdita del senso dell’olfatto e alterazione del senso del gusto. Tuttavia non presenta, invece, difficoltà a respirare, disidratazione e alterazione dello stato di coscienza. Va però detto che le persone anziane e chi è immunodepresso può presentare sintomi diversi e atipici. Ecco perché serve una valutazione specifica.
Le cure in ospedale
“In generale, chi ha sintomi di insufficienza respiratoria dovrebbe essere curato in ospedale e non a domicilio – spiega Bonfanti – tra la prima e la seconda ondata il grande passo in avanti è stato fatto grazie all’utilizzo dei farmaci corticosteroidi: nel nostro ospedale hanno dimezzato la mortalità (dal 23% all’11%, ndr.), sebbene la malattia si sia presentata esattamente identica nei due casi.
Va detto, però, che questi farmaci si sono dimostrati efficaci solo in chi aveva già sviluppato la polmonite e necessitava di ossigeno. Usati in fasi precoci della malattia, invece, finora hanno dato risultati contraddittori. Ricordiamo che molte persone guariscono da sole grazie al loro sistema immunitario e il cortisone può avere effetto dannoso, perché è immunosoppressivo.
Prescrivere ossigeno e corticosteroidi a casa dovrebbe essere una extrema ratio, nei casi in cui gli ospedali siano saturi, e richiede tele-monitoraggio e supervisione da parte del medico di famiglia e dell’ospedale”. Il modello degli hotspot – che sono stati creati contemporaneamente anche da altri ospedali, come il Sacco e il Niguarda, e che è stato poi promosso da Regione Lombardia – dovrebbe servire proprio a limitare situazioni di questo tipo.
Le cure a casa: cosa dicono le raccomandazioni
Per quanto riguarda tutti gli altri pazienti, cioè i casi lievi che possono essere seguiti al domicilio, le indicazioni sono quelle del Ministero della Salute nel documento Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2 (diramate a inizio dicembre scorso), che comprendono quelle dell’Aifa e sono avallate da vari ordini dei medici e dalla Società Italiana di Medicina Generale (Simg).
“Queste raccomandazioni sono accettate universalmente, ma sappiamo che in alcuni casi si fa ancora un uso non razionale dei farmaci, come la somministrazione indiscriminata ai primi sintomi di cortisonici, eparina o antibiotici, che invece andrebbero dati solo quando ci sono delle circostanze chiaramente individuate”, dice Claudio Cricelli, presidente Simg. “Per il resto – continua – l’indicazione è idratazione e, se serve, paracetamolo. Anche l’uso di antinfiammatori non steroidei (Fans) non deve essere considerato per tutti: l’unica strada è valutare caso per caso e bisogna evitare il fai da te”.
Ecco cosa prevedono le raccomandazioni per il trattamento domiciliare dei casi lievi, in 10 punti:
1 – vigile attesa (cioè monitoraggio)
2 – misurazione periodica della saturazione dell’ossigeno con il saturimetro
3 – trattamenti sintomatici (ad esempio con paracetamolo)
4 – appropriate idratazione e nutrizione
5 – non modificare le terapie croniche in atto per altre patologie (chi è in trattamento immunosoppressivo cronico potrà proseguire il trattamento in corso a meno di diversa indicazione da parte dello specialista che lo ha in cura)
6 – non utilizzare routinariamente corticosteroidi: l’uso dei corticosteroidi è raccomandato nei malati di Covid gravi che hanno bisogno anche della supplementazione di ossigeno
7 – non utilizzare eparina. L’uso di questo farmaco è indicato solo nei soggetti immobilizzati per l’infezione in atto
8 – non utilizzare antibiotici. Il loro eventuale uso è da riservare solo in presenza di febbre persistente per oltre 72 ore o se vi è il fondato sospetto o la certezza di una sovrapposizione di infezione batterica
9 – non utilizzare idrossiclorochina (la sua efficacia non è stata confermata in nessuno degli studi clinici controllati condotti finora)
10 – non somministrare farmaci mediante aerosol se si vive in isolamento con altri per il rischio di diffusione del virus nell’ambiente.
La lezione di Covid sulla medicina del territorio
“Sono venuto in ospedale perché il mio dottore mi dava solo paracetamolo” è una delle frasi che ci sentiamo dire più spesso. E la nostra risposta è che il medico stava facendo la cosa giusta”, spiega Alessandro Soria, infettivologo del San Gerardo: “In questi mesi non abbiamo solo curato i pazienti, ma li abbiamo studiati, abbiamo raccolto dati e ci siamo confrontati.
Abbiamo capito che avere un sistema organizzato con medici, infermieri di comunità, hotspot territoriali, tamponi con esiti in tempi rapidi serve a tenere le persone lontane dagli ospedali non grazie a chissà quale cura miracolosa – conclude Soria – ma perché consente di fare una buona selezione di chi in ospedale ci deve andare per forza e chi invece può stare a casa ad aspettare che la malattia faccia il suo corso”. È questa la lezione di Covid-19 sulla medicina del territorio.
 Unica Radio Raccontiamo la città che cambia
Unica Radio Raccontiamo la città che cambia