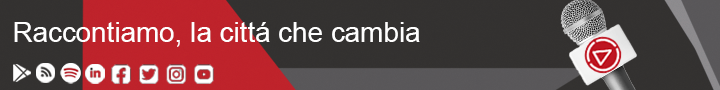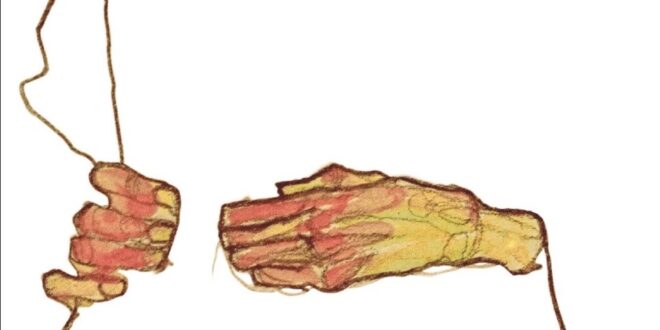La pandemia e le sue conseguenze hanno avuto fra i tanti effetti collaterali sulla psiche anche quello di far capire ai cosiddetti “sani di mente” che cosa significa avere una psicosi.
Lo sostiene Paolo Milone, per 40 anni attivo come psichiatra nel reparto di urgenza dell’ospedale di Genova e recentemente autore del libro L’arte di legare le persone, pubblicato da Einaudi, in questa intervista all’AGI.
Che conseguenze ha avuto la pandemia sui malati psichiatrici?
“Ce ne sono state tante, non tutte negative. La prima a cui penso è il fatto che molti pazienti psichiatrici tendono a mettersi in ‘lockdown’ da soli. Ci sono malati chiusi in casa da mesi, da anni. Sono schizofrenici, paranoici, depressi. Per loro che qualcuno dal di fuori obblighi tutti a stare a casa è un alleggerimento di responsabilità, non siamo noi a chiuderci in casa, ma qualcun altro. Discorso opposto per i maniacali che non stanno mai fermi e sfidano continuamente limiti e frontiere. Per loro non poter uscire è terribile”.
Quali sono invece gli effetti della pandemia su coloro che non hanno in precedenza avuto patologie di questo tipo?
“Sono soprattutto preoccupato per i bimbi piccoli. Hanno bisogno di stare con gli altri bambini. Il rapporto con i genitori è importante per lo sviluppo del cervello, ma i circuiti cerebrali, quelli che creano i sentieri per cavarsela nella vita, si formano nei primi anni di vita giocando con i coetanei. Sono le sinapsi che poi vengono percorse più rapidamente quando si cresce, e se non si formano giocando, creando una propria mimica, imparando a scontrarsi con gli altri, i sentieri non si formano e crescendo si rischia di perdersi nel bosco. Anche quanto giocano con loro, i genitori non bastano a sostituire i compagni nel gioco dei più piccoli”.
E sugli adulti?
“Il cosiddetto lockdown può far provare a tutti alcune delle sensazioni che sono tipiche dell’insorgere di una psicosi. In particolare penso a quella che noi psichiatri chiamiamo derealizzazione (il sintomo dissociativo che dà una percezione distorta della realtà, ndr). Poco dopo l’inizio della pandemia, il virus ha per così dire preso il controllo delle nostre vite. Un essere biologico invisibile riusciva a vincere su tutti i nostri mezzi, secoli di cultura e progresso, di leggi, di industria. Non siamo riusciti ad opporre resistenza e il coronavirus ci ha cambiato la vita.
Questa sensazione di impotenza, di inconoscibilità del nemico, può creare in tutti una piccola sensazione di derealizzazione. La realtà non è più quella che conoscevamo, non è quella relatà familiare e benigna. Il male può superare il bene. Il pericolo che rappresenta il virus è insormontabile non solo da me come persona, ma dalla nostra specie. Moltissime persone hanno provato questa ansia, un inizio di psicosi che nella maggior parte dei casi si supera, ma per i malati va avanti anni. Culturalmente è importante che chiunque abbia sperimentato su di se’ quello che è un inizio della psicosi, ovvero la sensazione di ansia e impotenza. E’ una delle tante porticine che si possono aprire sul mondo della psichiatria”.
Può spiegarci il titolo del libro sulla sua lunga esperienza in psichiatria d’urgenza, L’arte di legare le persone?
“E’ un titolo che allude a diverse situazioni in cui “si lega” in psichiatria. Il primo caso è un legame di tipo affettivo: significa legare i pazienti a noi, per creare una relazione che renda possibile al malato di distinguere fra se stesso e gli altri. C’è poi l’esigenza di legarlo a se stesso e alla realtà: nella psicosi, nel disturbo mentale generico, bisogna affrontare la depersonalizzazione, il fatto di non riconoscersi come entità unica e questo slega il malato da se stesso. Infine c’è poi la derealizzazione, il non riuscire a sentire la realtà come qualcosa in cui si vive, il sentirla distante. C’è, ma solo all’ultimo posto, la necessità, a volte, di dover legare il paziente al letto. Nella psichiatria d’urgenza è tutto un legare, un ricucire: in tutti i casi, alla fine si penserà a slegare”.
 Unica Radio Raccontiamo la città che cambia
Unica Radio Raccontiamo la città che cambia