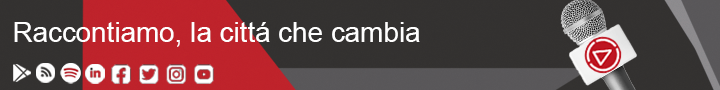Su Unica Radio parliamo con Massimo Aresu, insegnante e ricercatore; si occupa di storia delle comunità rom; attualmente collabora in qualità di visiting fellow con l’University of Leeds.
Il Prof. Aresu da più di un ventennio ha consacrato le sue indagini alla storia delle popolazioni rom europee. In questo appuntamento traiamo spunto dall’incontro tenutosi a Su Tzirculu il 6 marzo dal titolo “Nomadi apparenti. Comunità Rom tra stereotipi e vita quotidiana”.
Abbandonate l’immagine romantica dei rom che girano il mondo in roulotte: solo il 3% di rom e sinti in Italia sono nomadi. “Le famiglie nomadi sono pochissime e riguardano soprattutto alcuni Sinti giostrai e rom Kalderasha”. Entrambi i gruppi menzionati – precisa l’Anci – sono peraltro in gran parte nomadi di nazionalità italiana”. Una situazione che non cambia in Europa, dove gli 8-10 milioni di rom sono per l’85-90% sedentari. Eppure ai rom è chiesto di vivere come nomadi in roulotte o container. E se i campi sono sporchi e disagiati, forse non tutti sanno che la manutenzione è in mano al Comune. Mentre le costruzioni in cemento e il rifacimento delle strade sono vietate. Percorsi di integrazione e aiuto alla scolarizzazione, invece, sono affidati al terzo settore.
L’Italia è l’unico paese in Europa in cui esistono i campi rom come siamo abituati a conoscerli. Ovvero container o baracche di legno, gestiti dal Comune, dove i rom sono caldamente invitati a vivere in “condizioni inumane e degradanti”. A definirla senza mezzi termini sempre la Commissione diritti umani al Senato, che continua descrivendo una crudele emarginazione i cui effetti si riversano poi nella vita delle città. Politiche che hanno comportato voci di spesa elevatissime senza far registrare alcun miglioramento. Le condizioni di vita di rom e sinti hanno sistematicamente violato i diritti umani. Campi dove secondo la European Committee of Social Rights è impossibile condurre una vita dignitosa.
Come ribadisce Giulia Di Rocco: “Siamo 180mila, in pratica lo 0,23% della popolazione, solo il 3% è nomade. Solo in 26 mila vivono nei campi, eppure l’immagine che danno, soprattutto i media, è sempre quella del rom sporco, brutto e cattivo che vuole vivere in un campo. Ma quale persona sana di mente vorrebbe vivere in un campo se avesse la possibilità di vivere una vita dignitosa?”
Il nomadismo è certamente uno degli stereotipi più antichi
“Il nomadismo – come sottolinea il ricercatore Massimo Aresu – è certamente uno degli stereotipi più antichi e persistenti sulle popolazioni rom. Nato nel Medioevo, consolidatosi in età moderna ed affermatosi definitivamente in Europa nell’Ottocento, tale stereotipo si lega al presunto stile di vita di tali popolazioni, semplificando una realtà complessa: fin dal periodo basso medievale, infatti, in molti centri urbani europei sono attestate comunità stabili, o i cui movimenti si limitavano a spostamenti temporanei e a corto raggio. Si cercherà di riflettere su come la categoria di ‘nomade’ si sia caricata nel tempo di significati che vanno oltre il campo semantico originale, andando a marcare piuttosto la presunta inadattabilità dei Rom alla vita sociale organizzata, essenzializzandone i tratti, e sancendone la condizioni di eterni e irriducibili stranieri.
Su tale processo, che ha raggiunto il suo apice in età contemporanea e non si è ancora arrestato, si rifletterà a partire dal contesto sardo e italiano. Non solo l’Italia è uno dei paesi in cui l’antiziganismo è più diffuso, ma, col concorso delle istituzioni, nel senso comune si è radicata l’opinione che il campo nomadi rappresenti l’unico luogo in cui i Rom e i Sinti possano legittimamente abitare, a prescindere tanto dalla volontà dei singoli quanto dai diritti di cittadinanza posseduti”.
Rom viene dal sanscrito e significa “uomo”. Mentre Gypsies in inglese, Gitani in spagnolo sono forme contratte di Egyptiens e egipcianos. In francese non si trovano forme contratte nei documenti ma solamente la forma inalterata egyptien e solo dal XVI secolo abbiamo le forme moderne.
Secondo Leonardo Piasere “mentre Freher postula la discendenza diretta degli zingari dagli Athinganoi (setta eretica sviluppatasi in Asia Minore), Peucer postula l’identità nel presente tra zingari e Athinganoi; Bisciola, dal canto suo, è forse il primo che dice chiaramente che il termine “Cingarus” o “Cinganus” deriva da “Athinganos”, una teoria che persiste tutt’oggi anche se più di un autore ne ha dimostrato l’insostenibilità etimologica. Lo stesso autore è invece contraddittorio circa l’origine degli zingari in carne ed ossa. Se nel passo ora citato sembra schierarsi con Freher, poche righe dopo sembra seguire la “teoria Münster” dell’origine locale”.
Improprietà del termine “nomade”
“Per anni in Italia – racconta la Comunità di Sant’Egidio – si è utilizzato il termine ‘nomadi’ come sinonimo di rom, sinti o zingari. Negli ultimi anni, con l’affermazione di un linguaggio politically correct ‘nomadi’ ha avuto molta fortuna per definire le popolazioni rom e sinti presenti in Italia. I media lo hanno scelto e molte amministrazioni lo hanno introdotto nei propri documenti. Il termine però definisce popolazioni che vivono itinerando di luogo in luogo. Ma questa non è la realtà degli zingari presenti in Italia”. E se la parola “nomade” è impropria, il termine “zingaro” non può più essere usato. Anni di disinformazione e politica gridata, infatti, l’hanno fatta diventare un insulto.
Il Porrajmos, la tragedia nascosta
Il Porrajmos (o Samudaripen) è la parola che definisce il genocidio (circa 500000 morti) dei rom avvenuto tra il ’38 e il ’45 da parte dei nazisti e dei loro alleati. Un altro caso di (dis)informazione volutamente nascosta, una pagina di storia completamente insabbiata. Un olocausto dimenticato come racconta Giulia Di Rocco: “Poi quando vado nelle scuole, soprattutto per la giornata della memoria, nei libri di storia non c’è la nostra storia. Eppure noi abbiamo più volte fatto leva al ministero dell’Istruzione di inserire la storia anche dei sinti e dei rom”.
A questo proposito Luca Bravi sostiene: “Fino agli anni Ottanta, il Porrajmos venne giustificato dalla nazione tedesca come una politica di pubblica sicurezza attuata dal nazismo, quindi come una pratica differente dal progetto di sterminio razziale di un intero popolo. Così si negarono i risarcimenti che sarebbero spettati agli internati e ponendo il Porrajmos tra quelle categorie indicate come «le altre
vittime», dunque non sottoposte a sterminio razziale. È invece un dato inconfutabile che quella politica di sterilizzazione, internamento, uccisioni di massa che era stata messa in pratica su un’intera popolazione già dal 1933 in Germania, aveva colpito tutto un gruppo, a partire dai bambini in fasce, fino agli anziani. I motivi di quella persecuzione erano stati rintracciati da un’Unità d’igiene razziale del Terzo Reich che aveva indicato due tare ereditarie diffuse dal sangue «zingaro»: l’asocialità e l’istinto al nomadismo di
cui si misurò la presenza nel sangue delle varie famiglie rom e sinti già segregate in appositi ghetti, decretandone il grado di purezza”.
Il Romanes, una lingua volutamente mortificata
“Sicuramente incide – secondo Massimo Aresu – negativamente sul contesto la mancata applicazione per il romanes della legge 482/99. La legge fu tesa alla valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche nel nostro paese, ma escluse il romanes. La motivazione di questa scelta fu il mancato radicamento territoriale e il carattere “nomade” delle comunità rom e sinte italiane di antico insediamento. (Toso, 2008). Tale scelta per le comunità rom e sinte, che da più di mezzo secolo vivono stabilmente nella penisola, rende di fatto inapplicabile l’art. 6 della nostra Costituzione. «l’Italia tutela le minoranze linguistiche intese anche come minoranze etniche culturali, sia diffuse in modo minore in tutto il territorio sia insidiate in specifiche realtà territoriali».
“Chiudiamo con un paradosso, – continua Massimo Aresu – la discriminazione e il conflitto con le istituzioni hanno rappresentato nel tempo un ostacolo alla tutela linguistica. È un dato di fatto che in alcune regioni come la Sicilia e la Sardegna (un tempo incorporate ai domini asburgici mediterranei della Corona spagnola, dove la legislazione repressiva era più flebile), non solo si possa constatare l’assenza di comunità rom di antico insediamento. In Sardegna numerose famiglie sinte son presenti ma in forme invisibili e linguisticamente mascherate. La presenza del romanes è rilevabile solo residualmente in alcuni gerghi locali quali il baccagghiu dei camminanti siciliani e s’arromaniska dei calderai ambulanti di Isili in Sardegna“.
Si tratta di un’apparente incongruenza che mostra invece da un lato quanto sia profondo il radicamento delle comunità di cultura romanes nel nostro paese e dall’altro la necessità di nuove e approfondite indagini pluridisciplinari per restituirci la conoscenza di dati di contesto indispensabili per la corretta tutela di una lingua istituzionalmente bistrattata”.
La popolazione in Sardegna dei Rom arriva a 1300 unità.
 Unica Radio Raccontiamo la città che cambia
Unica Radio Raccontiamo la città che cambia